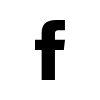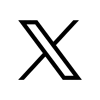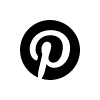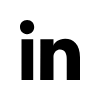Tutte le cose da sapere sulla 64ª edizione: date, orari, biglietti, i ritorni di EuroCucina / FTK – Technology For the Kitchen e del Salone Internazionale del Bagno, e le novità assolute come Salone Raritas, Salone Contract e l’installazione Aurea, an Architectural Fiction
Rodolfo Dordoni: rompere gli schemi e cambiare punto di vista

Rodolfo Dordoni with Suitcase armchair, Minotti. Photo courtesy
Riservato, razionale, discreto, l’art director Rodolfo Dordoni individua nello spostamento del punto di vista il fondamento della costruzione del suo rapporto con le aziende. Con la non trascurabile consapevolezza che piccoli gesti di rottura possano ridurre reciproche spigolosità e differenze. Perché art direction è anche condivisione di caratteri
Aggiornato il 1 agosto 2023. Per ricordare l’architetto e designer Rodolfo Dordoni, scomparso martedì 1 agosto 2023, ripubblichiamo questa intervista rilasciata a febbraio dello scorso anno. Milanese, classe 1954, una laurea in architettura conseguita nel 1979 al Politecnico di Milano, Dordoni è stata una delle firme più rilevanti della storia del design italiano contemporaneo. Nel corso della sua lunga carriera, oltre che autore di arredi per numerose aziende di design, è stato direttore artistico di Artemide, Cappellini, FontanaArte, Foscarini, Minotti e Roda.
Se prima le aziende si affidavano a questa figura per individuare una strategia e tutta una serie di mutazioni sulle quali non si erano interrogati, adesso la scelta è più meditata ed è anche più facile trovare gli interlocutori. Ai tempi in cui il racconto del design italiano era basato sui rapporti tra l’industriale e qualche progettista, erano poche le aziende che ne sentivano la necessità. Adesso gli art director sono diventati allenatori, registi di cui l’azienda ha bisogno, non tanto nel riconoscere e individuare una strategia quanto trasmetterla e indicare la strada.
Ho vissute entrambe le esperienze. All’inizio ero impreparato. Dopo la laurea in architettura, nel 1979, ho iniziato con Giulio Capellini, con il quale avevo fatto il mio percorso di studi. Voleva innovare l’azienda e mi chiese di collaborare. Ho iniziato - senza saperlo - facendo l’art director e ho proseguito per dieci anni.
Ho vissuto molto tempo dei primi anni sempre in azienda, con la possibilità di capire cosa volesse realmente dire un’azienda. Qui si capisce la differenza fra il ruolo di allora rispetto a quello odierno. Se prima era un ruolo da costruttore, ora è più da comunicatore. Ho vissuto la realtà aziendale dalla produzione alla comunicazione. Dove vivere l’azienda vuol dire fare, lavorare all’interno. Quando disegnavi, il primo aspetto con cui ti confrontavi era la fattibilità: costi, catalogo, possibilità produttive. Sono valutazioni e considerazioni di cui adesso non posso dire che non si tenga conto, ma non sono la base del progetto. All’epoca lo erano.
Il ruolo è cambiato con il mutamento dell’approccio al design e soprattutto alla comunicazione. Quando non esistevano i corsi di design, ci si formava da autodidatti. Solo con l’apertura delle scuole di design è nata la “squadra” di giovani professionisti, le aziende italiane hanno cominciato a guardare al design anche dall’estero e ad aprirsi ai punti di vista e alle sensibilità diverse. Da quel momento il ruolo è quello di cercare e riconoscere sensibilità che potessero fare gioco di squadra con un progetto già cominciato. Adesso, quando inizi una nuova avventura di art direction ti confronti con parametri differenti, comprendi chi potrebbe essere il compagno di viaggio con cui condividere questa visione di strade.

Suitcase armchair, Minotti, 1997. Photo courtesy
Art direction significa anche condivisione di caratteri. Nel mio ambito conservo l’aspetto razionale – mi reputo molto quadrato! - presupposto con cui costruire un rapporto di similitudini e coerenza. Non è possibile lavorare in un ambiente in cui stabilire una certa sinergia razionale, se con le persone dell’azienda non hai affinità… A volte ti trovi infatti a confrontarti con protagonismi che difficilmente riesci a mettere in equilibrio in un progetto che coinvolge più persone.
Devi fare in modo – ed è questo secondo me il ruolo dell’art director di oggi – che si crei equilibrio tra l’azienda e tutti i personaggi esterni e interni coinvolti nel progetto. Non si tratta solo di prodotto. Per una persona razionale come me se non c’è proporzione non c’è armonia: non lavoro su forme organiche, io sono costruito sul quadrato!
Il bello dell’art direction è che diventa parte della quotidianità. A differenza di opportunità più eclatanti o interessanti, il fatto di potere ragionare e lavorare con costanza cambia le modalità del lavoro. Non si pensa solo a un determinato prodotto ma agli aspetti che possano contribuire a far sì che possa non essere un insuccesso, limitando i rischi.

Suitcase armchair, Minotti, 1997. Photo courtesy
Minotti è la collaborazione più longeva (dal 1997): arrivai con una collezione composta da tre divani e una poltrona che era un cubo, aveva l’aspetto di un baule, Suitcase. Così è stato il primo approccio, una proposta basata su un oggetto che spostasse il punto di vista dando il “la” per i ragionamenti successivi. Ero convinto del loro rifiuto e invece si lasciarono incuriosire dalla provocazione minima, che però ha costruito la base per l’evoluzione futura dell’azienda. Si è trattato del cambio di prospettiva, dove il prodotto non era più il divano ma la collezione, una modalità propria del mondo della moda. Quindi, non più un progetto singolo ma un mood, un’atmosfera come punto di partenza per lavorare anche sul contesto. Per quella minicollezione (ora le chiamano capsule) avevo creato un microallestimento che la distinguesse all’interno dello stand al Salone… Volevo che si leggesse la differenza fra quell’insieme di prodotto e ciò che era già stato preparato per il Salone stesso. Capirono dove mi sarebbe piaciuto andare con loro e a me fu chiaro che potevano essere interessati a ciò che avremmo potuto fare insieme. Convincendo entrambi ad iniziare questa collaborazione.
Un altro episodio capitò quando Elle Decor decise di dedicare la copertina alla prima collezione realizzata con Minotti. In quell’occasione mi presentai con i capelli platino: non ci potevano credere! Devi rompere gli schemi se vuoi andare sotto la superficie. Il mio fu un gesto non di rottura ma di spontaneità per ridurre la distanza. Accettai con ironia di “essere platino” e loro altrettanto. Un gesto che ha contribuito a smussare spigolosità e differenze. Adesso siamo in buon allineamento.

Rodolfo Dordoni, ph credit Federico Cedrone
Sono scettico – oltre che poco preparato - sul virtuale… Non so cosa voglia dire: da buon razionale non mi incuriosisce questa mutazione che dà valore all’inesistente.
Penso che il metaverso sia l’ennesima opportunità di soddisfazione della curiosità, della vanità e di tutte le caratteristiche dell’animo umano. L’importante è riuscire a tenere alti lo stimolo e la curiosità. Secondo me il lavoro di art director sarà quello di contenere le esuberanze che possano stimolare questa sorta di vezzi, conservando la concretezza con cui conviviamo quotidianamente.
(È come quello che fanno gli chef con la cucina … va bene la “spuma” però io ho fame! Ti rimane la fame concreta. Quindi: saper fare le spume, ma anche dei buoni piatti!)
Mi piacerebbe che il ruolo dell’art director fosse quello di saper trasmettere la nostra tradizione, cultura, unicità, identità. Senza quello buttiamo ciò che ci ha resi unici.
Potrebbe essere quello di trovare - di nuovo - la sinergia fra sperimentazione, innovazione, sensibilizzazione ad argomenti di cui abusiamo, come la sostenibilità che diventa un atout per poter vendere. Deve essere un concetto insito, invece lo stiamo mettendo come etichetta per poter essere commerciabili.
L’art director ha la responsabilità di conservare il senso del nostro percorso, conservarlo e tramandarlo per il futuro.

Suitcase armchair, Minotti, 1997. Photo courtesy


 Storie
Storie