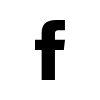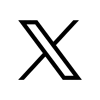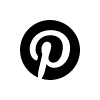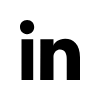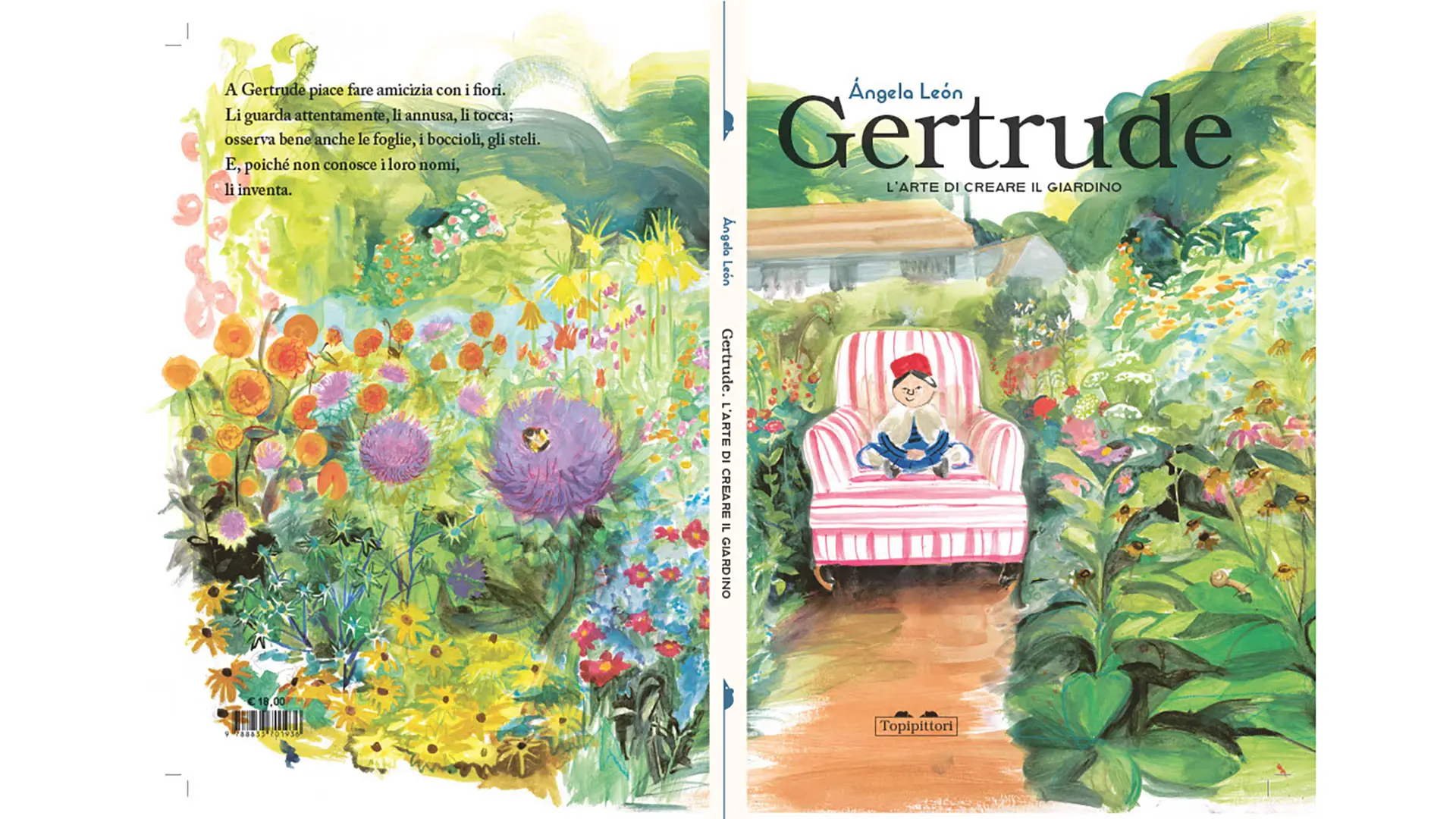Gio Ponti tra architettura, design e industria: dal Grattacielo Pirelli a Domus, fino agli arredi riletti attraverso il lavoro d’archivio

EX CAFFARRI, spazio della fondazione Reggio Children per capire il divenire della materia
La ricerca O.O.O., curato da Giulio Ceppi per Assufficio, analizza l’evoluzione di mentalità e spazi legati al mondo del lavoro. Per imparare a progettare nuovi uffici temporanei, con un occhio di riguardo all’inclusività
La presenza in ufficio? Oramai opzionale. La capacità di lavorare un po’ dappertutto, combinando al meglio impegni professionali e privati? Un dato di fatto. In questa fase di mutazione da ufficio fisico a ufficio ibrido, c’è chi vive lo slittamento degli spazi di lavoro come un pericolo, capace di intaccare le consuetudini e di erodere un mercato consolidato. E c’è chi, con gli occhi del ricercatore e l’esperienza del progettista, analizza i contorni del fenomeno per individuarne delle opportunità. Docente al Politecnico di Milano e fondatore dello studio Total Tool, Giulio Ceppi ha condotto per Assufficio un’analisi sull’identità in divenire degli uffici. Per mettere a fuoco i contorni di questo scenario e di questo progetto in divenire, Giulio Ceppi ha gentilmente risposto alle nostre domande.
O.O.O., come molti sapranno, è l’acronimo per “Out of Office”, nonché il titolo che abbiamo scelto per questa ricerca commissionata da Assufficio su spazi e abitudini di lavoro emergenti. L’esperienza del Covid ha accelerato un cambiamento già in corso, quella del telelavoro; una mutazione particolarmente sentita dalle giovani generazioni, che non desiderano più vincolare la loro presenza quotidiana all’interno di un ufficio corporativo. L’impatto di questo cambiamento è significativo: a causa della rotazione del personale tra ufficio e telelavoro, gli sviluppatori immobiliari assistono ad una contrazione importante delle superfici dei loro progetti. Allo stesso tempo, più usciamo dall'ufficio, più sconfiniamo ed occupiamo luoghi che apparentemente non sono deputati al lavoro: pensiamo a quanti lavorano in aeroporto, in un bar, negli hotel, in una biblioteca, un museo o un ospedale. Diventa allora necessario progettare degli spazi ibridi che funzionino bene per tutti: ed è qui che il tema del design for all, del progetto accessibile e inclusivo, diventa centrale.
Oggi nessuno nega l'importanza della natura all’interno dell’ufficio: potrà sembrare una moda, ma un ambiente più osmotico, metabolico, diventa centrale per il benessere. Ci sono poi i modelli americani, che associano l'ufficio ad un parco di divertimento. Molto significativo è anche il tema dell'arricchimento sensoriale, particolarmente rilevante negli ambienti di cura. Anche l’iper-personalizzazione diventa centrale: le persone non prediligono più l'open office a catalogo, ma soluzioni più sartoriali e in linea con un'identità più domestica. Infine, non possiamo non considerare il tema delle nuove tecnologie.
È un po' ingenuo pensare che l'ufficio resti solo il luogo della qualità delle relazioni umane. Pensiamo a quanto è successo alla fabbrica, che si è progressivamente svuotata dalle persone per trasformarsi in una catena automatizzata di robot. Non faccio fatica ad immaginare un ufficio che diventa un luogo dove ci sono le macchine più intelligenti. E mi sembra affascinante pensare che si tratterà di uno spazio dove io vado e interagisco con l'intelligenza artificiale. Il tema è sfidante: più le macchine diventano intelligenti, più hanno diritto di assumere delle configurazioni ancora da prevedere. L'Elea di Ettore Sottsass occupava una stanza, ma niente ci vieta di pensare oggi a delle forme diverse.
La checklist del design for all non esiste. In questo come in altri campi, è la maniera con cui affronti la complessità dell’inclusione che ti rende credibile – dunque ben oltre gli aspetti, certamente capitali, del rispetto delle normative o dell’accoglienza delle persone diversamente abili. Due anni fa ho chiesto ai miei studenti del Politecnico di identificare dei profili emergenti di fragilità: quando uno pensa all'inclusione l’immagine che emerge è quella delle persone in carrozzina, ma a volte il tema vero è sul piano cognitivo e psicologico. C’è una grandissima versatilità di esperienze tra chi lavora in modalità out of office, ed è proprio questa necessità di coadiuvare diversità e inclusione che può dar vita ad una nuova sperimentazione, tra vincoli ergonomici e normativi, diversità di mindset e creatività delle soluzioni. È proprio l’ibridazione il terreno su cui lavorare.
Dieci anni fa ho progettato un temporary office dentro l’Autogrill di Villoresi Est, che feci allora con l'aiuto di Luigi Bandini Buti, un bravissimo ergonomo che veniva da Olivetti: già allora avevamo colto come l'ufficio fosse un luogo inclusivo, necessariamente diverso dall’ufficio degli anni ‘70. Oggi dobbiamo capire che tutti noi abbiamo delle fragilità, delle difficoltà, dei problemi che sono anche molto variabili nel tempo. Del resto, la disabilità o la fragilità possono essere condizioni evolutive: basti pensare all'esempio banale della popolazione che invecchia. Per questo, credo sia importante disegnare in una maniera più morbida, più attenta a esigenze che sono di natura cognitiva, sensoriale e psicologica, oltre che motoria. E per farlo, è imprescindibile fare co-design: come progettista, non puoi pensare di sapere tu come risolvere un problema.
È una questione, a suo modo, di design democratico. Oltre al bespoke, al su misura, c’è uno spazio molto ampio per tutta la progettazione che tiene conto delle diversità umane. Io parlo sempre di diversità umana, perché da un lato è innegabile che esista la globalizzazione, ma dall'altra è vero che siamo sempre più diversi. Se un designer riesce a progettare in maniera interdisciplinare, tenendo conto di diversità che non stanno solo nella forma, ma anche nell'oggetto, nel servizio, nella comunicazione, nel carattere tipografico impiegato, etc., il risultato sarà più solido, versatile. Credo che questa sia un terreno di opportunità per il design italiano: oltre il feticismo per la grande icona, c’è molto da guadagnare da un approccio sistemico.
Il progetto è l’esito di una mostra che ho fatto quattro anni fa al Museo della Scienza con l’obiettivo di raccontare una serie di fenomeni culturali, sportivi, politici, ed economici connotati da un colore: dalla green economy alle quote rosa, dal telefono azzurro alla zona rossa e alla silver economy. Il format ha funzionato, trasformandosi in una serie di quaderni per Pigna. Credo che a volte storicizzare alcuni momenti attraverso le immagini, soprattutto di fronte alle giovani generazioni, possa essere efficace. Se si parla di pedagogia però, ancora una volta lo sguardo deve essere molto ampio. Di fronte alla necessità di adattare i nostri sistemi educativi alle sfide del presente, i mobili possono sicuramente giocare la loro parte, ma non basta certo mettere le rotelle ad una sedia per trasformare – pensiamo a cosa è stato fatto per altre ragioni durante la pandemia - un sistema scolastico in un modello interattivo e virtuoso.


 Storie
Storie